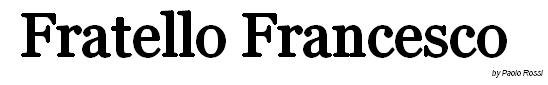Canto XI del Paradiso di Dante Alighieri

Dante Alighieri (Firenze, tra il 22 maggio e il 13 giugno 1265 – Ravenna, 14 settembre 1321), il sommo poeta della nostra letteratura, fu certamente colpito dalla figura del poverello di Assisi: nella sua opera principale, la Commedia, Francesco compare più volte, ma l’episodio più significativo è la sua lode, che formula nel punto più alto dell’opera: il Paradiso.
Quando Dante nacque, nella Firenze da poco comunale del 1265, l’Ordine francescano si era già ampiamente diffuso e sviluppato, ed era diventato importante anche in ambito universitario, soprattutto grazie all’opera di s. Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale dell’Ordine, che insegnava all’Università di Parigi ed aveva redatto, nel 1259, alla Verna, la sua opera teologica più famosa: l’Itinerarium mentis in Deum; in quegli anni, attorno alla metà del 1200, egli veniva considerato tra i più grandi maestri della scuola parigina, insieme al domenicano s. Tommaso d’Aquino.
Le loro posizioni filosofiche sono piuttosto lontane:
- i domenicani nascono come predicatori, lottano contro l’eresia, perciò mirano a convincere con la ragione, che diventa con Tommaso la via principale, per indagare e approfondire le verità di fede, ed è indispensabile strumento che Dio stesso ci ha donato;
- i francescani assumono il Vangelo come stile di vita, e sono più propensi invece alla contemplazione del creato: Bonaventura (come s. Francesco nel Cantico delle Creature) vede che la natura e l’anima dell’uomo sono come impronte di Dio, e queste diventano il mezzo per avvicinarsi, per quanto ci è possibile, a Lui: l’esperienza mistica rappresenta la conoscenza vera e propria del Creatore e solo da Lui dipende, non dalla ragione umana, che può aiutare l’uomo solo ad arrivare ad un livello intermedio.
Non esistono notizie certe sui primi contatti di Dante con ambienti francescani: commentatori anche di poco successivi, ipotizzarono che egli in gioventù fosse stato novizio, per poi uscire dal convento prima di prendere i voti. Ma quello che Dante stesso ci dice della sua giovinezza non sembra confermare questa ipotesi: verosimilmente egli compì i primi studi in ambiente religioso, cosa peraltro comune a quel tempo, forse alla scuola del convento francescano di S. Croce in Firenze.
Frequentò poi nuovamente questo ambiente e la scuola domenicana di S. Maria Novella, per cercare conforto negli studi filosofico-teologici in un momento doloroso, la morte di Beatrice, avvenuta nel 1290 (come scrive nel Convivio e nella Vita Nuova).
Il primo interesse del giovane Dante è «lo scriver per rima», sancito anche dal sodalizio con Guido Cavalcanti e altri poeti, e dagli insegnamenti del maestro Brunetto Latini: sono gli albori del «Dolce Stil Novo» (definizione che pronuncia il poeta Bonagiunta Orbicciani da Lucca nel canto XXIV del Purgatorio), che Dante costantemente riprende e ridefinisce, in un percorso che va dalla prima produzione in rima, alla Vita Nuova, al Convivio, alla Commedia stessa: Beatrice, la donna cantata in gioventù secondo lo stile della lirica cortese, che eleva e ingentilisce l’animo del poeta e addirittura di chiunque la incontri, dopo la sua morte viene dimenticata, e l’amore sostituito dall’interesse umano per la filosofia; ma nel Paradiso ritorna trionfante come simbolo della teologia, che guida verso Dio, prima e unica fonte di amore, l’uomo Dante e, tramite lui (con la Commedia), tutta l’umanità.
Dante era stato destinato fin da piccolo al matrimonio con Gemma Donati (celebrato nel 1295), che faceva parte di una famiglia legata allo stesso gruppo politico degli Alighieri, i Guelfi bianchi.
Egli è molto orgoglioso della sua appartenenza alla piccola nobiltà cittadina: partecipò alla battaglia di Campaldino nel 1289, come feditore a cavallo contro gli aretini e i ghibellini di Toscana, e cominciò ad appassionarsi alla vita politica di Firenze, tanto da arrivare a far parte del Consiglio dei Cento e del Consiglio del Podestà, e ricoprire perciò la carica di priore.
Proprio in questo periodo è costretto a prendere fortemente posizione nelle lotte intestine tra Bianchi e Neri, al punto da votare, nel Consiglio dei Priori, l’esilio di sedici esponenti delle due fazioni, tra i quali il suo amico Guido Cavalcanti.
Egli fu il capo dell’ambasceria inviata dal «governo bianco» nel 1301, presso papa Bonifacio VIII, per chiedergli di rinunciare ad intervenire nelle vicende cittadine.
Ma nel frattempo a Firenze i «Neri» presero il potere con la forza (appoggiati dallo stesso papa), istituirono un processo contro i priori dell’ultimo biennio, i quali vennero condannati all’esilio in contumacia nel 1302.
Tra costoro è Dante stesso, che così non poté mai più far ritorno in patria, ma decise di prendere la strada delle corti dell’Italia settentrionale e centrale: la dura esperienza dell’esilio (fino alla morte a Ravenna nel 1321), rappresenta un evento fortemente doloroso, l’abbandono «di ogni cosa diletta più caramente» (Pd. XVII, v. 55), e segnerà ogni suo scritto successivo.
Ma nonostante la sofferenza egli rifiutò la possibilità di far ritorno, che gli venne offerta nel 1315, pur di non sottostare all’umiliazione di dover chiedere perdono di reati che non aveva commesso, e subì addirittura la condanna a morte in contumacia.
Il suo pensiero politico-religioso, segnato anche da questi avvenimenti dolorosi, teorizza una netta divisione tra l’incarico della Chiesa e quello dell’Impero: la prima è la depositaria della Rivelazione e via per la salvezza dell’anima, ma, per Dante, non può possedere alcun bene o potere temporale, che Dio ha affidato invece ai sovrani per garantire la pace e la giustizia in questo mondo.
Egli perciò non può che criticare vivacemente l’operato del papa in diverse occasioni, in particolare per la sua ingerenza nelle scelte politiche della sua Firenze, ma anche l’indifferenza dell’imperatore per le sorti dell’Italia, affidata legittimamente al suo governo, come possiamo leggere nelle tredici epistole che ci sono rimaste delle molte che inviò a cardinali, podestà e al sovrano stesso, Enrico VII.
Questo incompleto e breve ritratto del poeta sembra darne un’immagine piuttosto lontana dalla serenità francescana e dal distacco dalle cose mondane tipico del convento.
Tuttavia altre fonti sostengono che Dante, fermatosi finalmente dopo il suo lungo peregrinare nelle corti italiane, nella città di Ravenna, sia entrato nel Terz’Ordine Francescano (è sepolto nella chiesa del convento di S. Francesco d'Assisi), ed anche un dipinto di Giotto nella basilica di Assisi pare che lo ritragga in queste vesti.
Il fatto risulta verosimile, vista la grande ammirazione di Dante per il santo di Assisi, lui che criticava aspramente le ricchezze e la corruzione della Chiesa, dimentica, a quei tempi, delle sue origini nella povera grotta di Betlemme.
Nella Commedia, Francesco fa una breve apparizione addirittura nell’Inferno, nel tentativo di salvare dalla dannazione l’anima fosca di Guido da Montefeltro, il quale si era fidato dell’assoluzione precedente il peccato, che papa Bonifacio VIII gli prometteva in cambio del consiglio giusto per eliminare i suoi avversari politici.
Nel Paradiso, poi, nel canto XII, 44-45 e 110-112, s. Bonaventura, dopo aver lodato la vita di s. Domenico, parla dei francescani degeneri e dei monaci corrotti, lontani dalla purezza del loro santo fondatore; ancora, in XXII vv.88-90, s. Benedetto ricorda che «Pier cominciò sanz’oro e sanz’argento, / e io con orazione e con digiuno, / e Francesco umilmente il suo convento»; infine, il posto di s. Francesco nell’Empireo dei beati è in una posizione privilegiata, subito sotto s. Giovanni Battista e di fronte alla Vergine (XXXII, 27-35: «E come quinci il glorioso scanno / della donna del cielo e li altri scanni / di sotto lui cotanta cerna fanno, / così di contra quel del gran Giovanni, / che, sempre santo, ‘l diserto e ‘l martiro / sofferse, e poi l’inferno da due anni; / e sotto lui così cerner sortiro / Francesco, Benedetto e Augustino, / e altri fin qua giù di giro in giro»).
Ma la vera celebrazione è nel canto XI, vv.28-117, nel quale il domenicano s. Tommaso d’Aquino racconta la vita straordinaria del santo di Assisi, situazione che si ribalterà nel canto seguente, in cui il francescano s. Bonaventura da Bagnoregio elogerà s. Domenico di Guzman, a sottolineare la fratellanza evangelica tra i due fondatori, e a rimproverare l’odio terreno a cui erano giunti i loro seguaci.
Dante, guidato da Beatrice, è arrivato al quarto dei nove cieli di cui è composto l’Empireo, precisamente a quello del sole, nel quale si trovano gli spiriti sapienti: il primo beato che incontra è s. Tommaso d’Aquino, accompagnato dal suo maestro Alberto Magno e da altre dieci anime.
Egli, come poi s. Bonaventura nel canto seguente, spiega a Dante l’importanza dei due santi fondatori: Gesù «sposò» la Chiesa con il sacrificio del suo sangue, ed ebbe cura di lei tanto da affidarle due principi, che le fossero di guida, diversi fra loro per poter offrire un sostegno migliore: Francesco, acceso di mistico ardore di carità come un Serafino, e Domenico, luminosamente sapiente come un Cherubino.
Lodandone uno, si esalta allo stesso modo anche l’altro, perché entrambi in vita avevano un unico scopo: il bene della Chiesa.
Comincia così il racconto della vita di Francesco da parte del domenicano Tommaso: la città di Assisi, da cui nacque il «Sole-Francesco», viene celebrata in ben quattro terzine, segue poi la giovinezza del santo, tutta incentrata sulla metafora del suo amore per Madonna Povertà, talmente forte da indurre altri a seguirlo.
Poi, cresciuta la famiglia francescana, Tommaso insiste sul «sigillo» papale ricevuto da Innocenzo III, e successivamente anche da Onorio III; il terzo segno, che lo rese veramente «alter Christus», furono le stimmate, ricevute «nel crudo sasso intra Tevero e Arno».
Vi è anche una parentesi sulla missione di Francesco in terra d’Oriente, dinanzi al saladino, in cui si sottolinea il desiderio di sacrificare la propria vita; invece la morte avvenne sul suolo natio, lasciando alle cure dei suoi frati il bene più prezioso: Madonna Povertà.
Tommaso termina ribadendo che la stessa grandezza fu nel suo patrono, s. Domenico, sebbene i suoi seguaci non siano più in grado di eguagliare la grandezza del fondatore, e ne abbiano abbandonato il sentiero, attratti dallo studio di cose vane, che finiscono per svuotarli della loro sapienza.
![]()